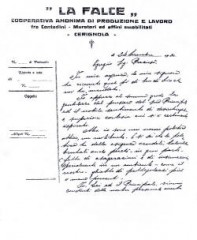Già un caso editoriale in Francia, esce anche in Italia per Donzelli “Il veterano. Undici anni nei campi di concentramento (1934-1945)” di Carl Schrade. Come scrive Alessandro Portelli nella prefazione che qui pubblichiamo, questa straordinaria testimonianza è “uno studio su che cosa può l’umanità in condizioni estreme”.
 Arrestato nel 1934 all’uscita di un caffè berlinese per aver pronunciato alcune frasi critiche sul regime hitleriano, il giovane commerciante svizzero Carl Schrade diventerà un «veterano» dei campi di concentramento nazisti, trascorrendovi undici anni della sua vita e passando per una impressionante, penosa serie di luoghi, dai nomi tristemente noti: Lichtenburg, Esterwegen, Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg. Dopo la liberazione e il processo di Dachau, nel quale si troverà a testimoniare contro i responsabili delle atrocità cui aveva assistito, in particolare quelle commesse ai danni dei malati da parte dei medici nazisti, Schrade comincia a trasferire sulla carta i suoi terribili ricordi.
Arrestato nel 1934 all’uscita di un caffè berlinese per aver pronunciato alcune frasi critiche sul regime hitleriano, il giovane commerciante svizzero Carl Schrade diventerà un «veterano» dei campi di concentramento nazisti, trascorrendovi undici anni della sua vita e passando per una impressionante, penosa serie di luoghi, dai nomi tristemente noti: Lichtenburg, Esterwegen, Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg. Dopo la liberazione e il processo di Dachau, nel quale si troverà a testimoniare contro i responsabili delle atrocità cui aveva assistito, in particolare quelle commesse ai danni dei malati da parte dei medici nazisti, Schrade comincia a trasferire sulla carta i suoi terribili ricordi.
Questo documento, affidato all’amico Jehan Knall-Demars, figura storica della Resistenza francese, che ospitò Schrade nella sua casa di Nizza, resterà sepolto per settant’anni, prima di vedere la luce oggi, diventando in Francia un vero e proprio caso editoriale. Nel libro Schrade segue fin dall’origine la lunga evoluzione del sistema concentrazionario, osservando in tutte le sue fasi, il cambiamento nella logica dei campi e nella provenienza dei prigionieri e degli internati. Lavori logoranti, umiliazioni, violenze gratuite, malattie, epidemie, rapporti umani retti nella maggior parte dei casi dalla negazione dell’umanità stessa: la radiografia di Schrade non risparmia niente. Come osserva acutamente Alessandro Portelli nella sua prefazione, la scrittura di Schrade, incredibilmente precisa e lucida, conserva una rara capacità di riconoscere anche nelle vittime gli effetti del degrado e della corruzione: a sottolineare come «il rischio di essere aguzzini o complici è parte di noi in quanto esseri umani».
Carl Schrade nasce nel 1896 a Zurigo. Dopo la prima guerra mondiale intraprende l’attività di commerciante, e spesso si reca in Germania per lavoro. È qui che una sera, in un locale berlinese, si lascia andare a una critica del regime nazista. Verrà arrestato e da quel momento inizierà la sua odissea, fino alla liberazione. Nel 1946 testimonia nel processo di Dachau contro il medico nazista Heinrich Schmitz, responsabile di terribili crimini nell’ospedale del campo di Flossenbürg, dove Schrade aveva lavorato mettendo a rischio la propria vita per salvare prigionieri e malati. Il ritorno in Svizzera non sarà facile, e Schrade troverà rifugio in Francia, presso gli amici con cui aveva condiviso gli anni di internamento. Schrade muore nel 1974 dopo una lunga malattia.
Per gentile concessione dell’editore proponiamo la prefazione di Alessandro Portelli a “Il veterano. Undici anni nei campi di concentramento (1934-1945)” di Carl Schrade, in questi giorni in libreria per Donzelli.
di Alessandro Portelli
Nei primi capitoli della sua autobiografia, l’ex schiavo americano Frederick Douglass descrive la gerarchia della piantagione e le figure degli overseers, i sorveglianti che la facevano funzionare: «Il signor Plummer era un miserabile ubriacone, uno spergiuro, e un mostro fatto e finito. Circolava sempre armato di uno scudiscio di pelle di bue e di un pesante bastone…». «Mr. Severe si chiamava per quello che era: un uomo crudele. L’ho visto frustare una donna da farle colare il sangue per mezz’ora». La grandezza dell’autobiografia di Douglass sta nella capacità di rovesciare lo sguardo: gli over-seers, coloro che, letteralmente, «vedono dall’alto» e sanno tutto, sono guardati dal basso e giudicati per quello che sono da chi non dovrebbe sapere niente. E il mero fatto di saper vedere e giudicare conferma quello che l’intera istituzione della schiavitù pretende di negare: la soggettività, la capacità di giudizio morale, di esseri umani trattati disumanamente come subumani.
Ubriaconi brutali armati di frusta e bastone circolano anche nei campi di concentramento nazisti dove Carl Schrade ha trascorso gli undici anni che descrive in questo libro. Anche Schrade guarda la gerarchia del campo e la descrive in termini non molto diversi da quelli di Douglass. Il comandante del campo di Flossenbürg, «il tenente-colonnello SS Karl Künstler, alto, snello ed elegante, ha due passioni: il cavallo e l’alcol»; come gli aristocratici padroni delle piantagioni, non picchia mai nessuno ma lascia fare ai suoi subalterni, il capitano SS Aumeier («un genio del male»), il sergente capo SS Schirmer («un vero e proprio bruto pieno di fiele»), il sottotenente SS Tromer («un macellaio molto rispettabile, un boia di talento»).
Parole come «schiavi» e «schiavitù» ricorrono spesso nel racconto di Carl Schrade sui suoi undici anni di prigionia nei campi di concentramento nazisti («le SS non avevano affatto bisogno di rispettare il detenuto-schiavo. Così come non rispettavano alcun essere estraneo alla loro casta e al loro “onore”»). Non è solo una metafora: il campo di concentramento prepara il campo di sterminio, anche se non ha ancora come fine la morte delle sue vittime, ma piuttosto condivide con la piantagione schiavista l’intento di estrarne il massimo di lavoro e sottoporle a una subalternità totale, mettendone in conto tranquillamente la distruzione e la morte se servono alla produzione o alla disciplina. Le gerarchie del campo, come quelle della piantagione, si legittimano con la convinzione di sentirsi esseri superiori preposti a creature senza alcun diritto («Voi, i detenuti, siete esclusi dalla comunità nazionale. Non siete più uomini», dice l’aiutante SS Reinicke, che Schrade bolla come «megalomane»).
Come vede bene Frederick Douglass, è anche per rinforzare in se stessi questa persuasione di onnipotenza che si accaniscono a disumanizzare le loro vittime e a distruggerle a casaccio: l’onnipotenza lascia libero il sadismo, il piacere in sé di fare male, di umiliare, di uccidere «per ridere». Tanto più che, a differenza degli schiavi, i detenuti del campo non hanno neppure quel valore commerciale che, nelle piantagioni, poteva indurre a pensarci due volte prima di sprecare inutilmente le vite di quegli utili e costosi animali da lavoro che erano gli schiavi. Per il regime concentrazionario del Terzo Reich, la fornitura gratuita di sempre nuovi detenuti-schiavi sembra, dall’inizio del regime fino alla fine della guerra, praticamente inesauribile.
L’acutezza dello sguardo dal basso si conferma, in Schrade come in Douglass, anche nella capacità di continuare a distinguere, di vedere i loro aguzzini come individui uno diverso dall’altro. Douglass scrive che il nuovo sorvegliante, Mr. Hopkins, era «meno crudele, meno empio, meno chiassoso… frustava, ma non pareva ci provasse gusto. Gli schiavi lo giudicavano un sorvegliante umano». E Schrade menziona l’aiutante SS Mayrl, che «non era un tipo cattivo» («n’était pas mauvais bougre»); il tenente SS Petz, «uomo calmo e corretto»; il «brav’uomo di nome Seiz, del quale non abbiamo niente di male da dire». Sia in Douglass che in Schrade, la relativa umanità di alcuni si misura non sul possesso di qualità positive, ma sulla mancanza o attenuazione dei tratti di crudeltà di tutti gli altri. L’unica vera eccezione è Max Demmel, il sottufficiale addetto alla sorveglianza nell’infermeria, che non si limita a essere meno crudele ma è positivamente buono: «ci dà il suo aiuto e il suo caritatevole appoggio. Anche lui commette furti per soccorrerci. Ma non traffica, non intasca niente. Quello di cui dispone, lo dà sinceramente e senza secondi fini […]. Tutto quello che vede qui, tutto quello che sente, gli suscita disgusto e ripugnanza. Si capisce che è sincero e onesto […], è talmente dolce e umano che i detenuti ne riconoscono la naturale bontà e lo soprannominano “l’Angelo”» – l’unico che Schrade incontra in undici anni d’inferno.
C’è ironia implicita in questa definizione, «angelo», in un luogo che è ripetutamente descritto come un «inferno». E infatti: «I collaboratori di Loritz, il capo del campo degli internati Schmitt e il Rapportführer Terrey, erano angeli devoti al padrone. Operarono talmente bene che, grazie all’unione dei loro talenti, quel campo fu chiamato l’“Inferno della foresta”». Con Frederick Douglass, infatti, Schrade condivide un altro procedimento retorico: l’uso dell’ironia, del sarcasmo, dell’ossimoro. Nel mondo alla rovescia della piantagione e del campo, ogni cosa diventa il proprio contrario e il significato delle parole si capovolge, e gli angeli sono demoni. Per Douglass, il terreno principale dell’ironia e dell’ossimoro è la «religione schiavista» dei «pii aguzzini cristiani», come Mr. Covey, «anima pia» e «domatore di schiavi»; in Schrade, i luoghi dove si verifica più stridente la contraddizione sono il patriottismo e la professionalità.
«Recht oder Unrecht, mein Vaterland», nella ragione o nel torto, è il mio paese: questo «motto stupefacente» ossessiona Schrade anche più del ben noto «Arbeit macht Frei», perché fa del «torto» una virtù patriottica. Più si accaniscono sulle proprie vittime, più inventano nuovi modi di privarle dei loro diritti, e più gli aguzzini affermano di stare servendo il loro paese. E per servire il loro paese, devono mettere a frutto tutte le loro capacità: «Meravigliosi strumenti nelle mani di un Padrone feroce, i Kaiser avevano davanti a loro un brillante avvenire: nel 1936», con i loro collaboratori, «per le eccezionali qualità dimostrate, furono assegnati al campo di Dachau, dove perseguirono fino al limite estremo il loro compito, benedetto dal Führer». Così, Koch, il comandante di Buchenwald, è descritto sarcasticamente come «un uomo integro, circondato da consiglieri virtuosi». Il campo stesso diventa la materializzazione di questo paradosso, a partire dal bucolico nome assegnato a questo inferno, «foresta di faggi». Buchenwald è il prodotto dell’ingegno e del lavoro umano: «A Buchenwald ci sarebbero volute milioni e milioni di ore di lavoro consumate da migliaia e migliaia di esseri umani per innalzare quel gigantesco monumento che in capo a qualche anno avrebbe raggiunto la perfezione quanto a ordine, armonia, solidità e resistenza».
Il dottor Schmitz, capo dell’infermeria di Flossenbürg, «un giorno dichiarò a uno di noi che 10-12 000 cadaveri in un anno erano un “bel risultato”». Il capovolgimento del senso e delle parole culmina negli ospedali dei campi: il sapere medico e scientifico non serve a curare ma a torturare e a uccidere. Il tenente SS Tromer, medico a Flossenbürg, «aveva sbagliato vocazione. Sarebbe stato un macellaio molto rispettabile, un boia di talento» che amava l’arte, la musica, i fiori e massacrava le persone. Il dottor Schmitz è l’incarnazione più estrema di questo rovesciamento del senso: «chirurgo dotato di un vero talento, quest’uomo privo di ogni senso morale, che si avvale di un’intelligenza pronta e vivace», fa dell’infermeria un regno di «terrore e follia». E niente meglio dell’implicito ossimoro di una follia retta da una viva intelligenza e da un vero talento dà conto della qualità dello sguardo che Schrade getta sulla macchina concentrazionaria e sui suoi amministratori.
In questo libro pieno di episodi drammatici e scene spaventose, forse l’episodio più «commovente», «toccante» e infine semplicemente «bello» è l’incontro con la donna che vedendo passare per il suo villaggio la colonna dei prigionieri, supplica il capo degli aguzzini di fermarsi, «per l’amor del Cielo e dei suoi figli». L’immagine che ne resta negli occhi delle vittime, di lei spinta via a forza e inginocchiata al bordo della strada, è il momento più alto di umanità. Ma proprio la compassione di questa donna diventa anche il più duro atto d’accusa nei confronti di tutti gli altri, di tutta la gente che li vede passare e non fa e non dice niente, per paura, per indifferenza, per complicità.
La donna di Hottelstedt e l’angelico infermiere Max Demmel sembrano, a prima vista, varianti della grande narrazione sul «tedesco buono» (pensiamo al Disperso di Marburg di Nuto Revelli) che spicca fra i suoi sanguinari camerati a dimostrazione del fatto che «non tutti i tedeschi erano cattivi». Spesso questa figura, in parte reale e in parte mitica, è stata evocata con funzioni assolutorie: tutto sommato le SS non erano poi così cattive, anche la piantagione manteneva tratti di umanità, e così via. In realtà, significa il contrario: il fatto che alcuni membri della gerarchia si distinguessero perché mantenevano tracce della propria umanità non fa che sottolineare le responsabilità di tutti gli altri. L’esistenza del sorvegliante caritatevole mette in risalto la malvagità del medico assassino.
Vedere le SS come individui sottolinea il fatto che le responsabilità sono anche responsabilità personali: si poteva anche provare a essere un po’ diversi. Anche per questo, oltre che per motivi di accuratezza e verificabilità storica, è importante il fatto che Schrade ci tenga a ricordare il più possibile i nomi, le storie, gli atteggiamenti: fanno tutti parte dello stesso sistema, della stessa macchina, ma non sono meri meccanismi intercambiabili, ci stanno dentro ognuno a proprio modo e con le proprie scelte.
Schrade mantiene la stessa lucidità, la stessa capacità di distinguere, anche nei confronti dei propri compagni di sofferenza: riconosce gli eroi, i santi, i martiri; e riconosce i traditori e le spie. Mostra come il campo fosse in grado di produrre degrado e corruzione anche tra le stesse vittime (il capitolo sulla sessualità è tra le pagine più insolite e tristi di tutta la letteratura concentrazionaria), e come la gerarchia nazista fosse in grado di sfruttare le loro divisioni e le loro debolezze. Ma è tutto il libro che diventa, infine, uno studio su che cosa può l’umanità in condizioni estreme: «È certo che in nessun’altra situazione ci sarà possibile studiare e comprendere meglio l’uomo, la sua natura biologica e psicologica, che in un contesto di sofferenze e di prove quale è un campo di concentramento come quello di Flossenbürg», scrive Schrade. È un altro modo di dire, con Primo Levi, che «è avvenuto, quindi può accadere di nuovo». Il rischio di essere aguzzini o complici è parte di noi in quanto esseri umani. Schrade ci chiama alla vigilanza su noi stessi.