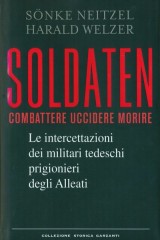Fra una settimana sarà il libreria un mio nuovo libro. Il settimo (come unico e solingo autore). Ma stavolta c’è qualcosa di nuovo, insieme a qualcosa di solito. Il nuovo è che, chi vorrà, si troverà fra le mani un romanzo (“Il patto di Katharine”), il primo di quella che aspira ad essere una serie (“Gli strani casi di Dario Lamberti”). Il solito è che si parla ancora di storia, 1941 per la precisione, Reggio Emilia per l’esattezza.
Fra una settimana sarà il libreria un mio nuovo libro. Il settimo (come unico e solingo autore). Ma stavolta c’è qualcosa di nuovo, insieme a qualcosa di solito. Il nuovo è che, chi vorrà, si troverà fra le mani un romanzo (“Il patto di Katharine”), il primo di quella che aspira ad essere una serie (“Gli strani casi di Dario Lamberti”). Il solito è che si parla ancora di storia, 1941 per la precisione, Reggio Emilia per l’esattezza.
Perchè passare dalla storia alle storie? Qualcuno, con il pennacchio sul cappello, storcerà il naso e penserà “Ecco, ve l’avevo detto: Storchi non è una storico serio, si mette a scrivere romanzi…”. Devo dire che di questi pennacchiuti ne ho pieni i cabasisi e che mi fanno ormai l’effetto di un Cicchitto alle due del pomeriggio. Leggera nausea e totale indifferenza. Tranquillizzo i pochi affezionati tossici: continuerò a far ricerca e a pubblicare i saggi con note, citazioni, glosse e quant’altro. Però. Però non posso nascondermi dietro a un dito e negare la crisi profonda della storiografia italiana contemporanea. Escono saggi perfetti, frutto di approfondite ricerche e rigorose meditazioni e…nessuno li legge. Salvo beninteso la ristrettissima cerchia degli addetti ai lavori, loro famigli compresi. Saggi perfetti che rimangono muti, incapaci di formare una consapevolezza pubblica. Editi magari da editori che non diffondono il prodotto oltre i confini comunali. Così l’opinione pubblica rimane ferma in convinzioni assolutamente fallaci (dalle colpe partigiane per le Fosse Ardeatine, al “mito” delle foibe o i presunti “crimini” partigiani del dopoguerra) e giorno per giorno la domanda “ma noi storici che ci stiamo a fare…?” diventa sempre più scomoda.
Io sono uno storico di strada, non sono un uomo di cultura, raccolgo pezzi di vita e cerco di rimetterli insieme. Tutto qui. Non avrò mai una cattedra universitaria o, se dovessi averla, sarebbe quella da bidello magari alle elementari di Fortezza Bastiani. Non sono abbastanza bravo, complesso, profondo. Ma, peggio di tutto, pare che riesca a farmi capire. Imperdonabile. Perchè interpreto il mio essere storico come un impegno etico e culturale, perfino politico. Non pubblico 3 saggi all’anno per avere 1,38 punti per il prossimo concorso, peraltro già assegnato a tavolino. Scrivo e parlo perchè la gente capisca, non perchè rimanga affascinata (o mortalmente annoiata) dal mio scrivere/parlare ma perchè porti a casa o trovi nei miei libri una sola nota in più di quanto conosceva prima. Lo so, è sbagliato, in un paese dove anche fra gli storici la gara è spesso(mi scusino le signore) a chi ce l’ha più lungo.
Qualche anno fa proposi una mia ricerca a un sommo editore che la valutò, la soppesò e poi rispose “no, grazie, è troppo locale..”. Al suo posto editò un sontuoso saggio accademico che vendette ben 78 copie. La mia ricerca, (il volume si chiamò “Sangue al Bosco del Lupo”) pubblicata dall’amico Francesco Aliberti vide andare esaurite due intere edizioni, con una pagina intera sul “Corriere della Sera”. Fortuna, certamente, ma anche la dimostrazione di quanto antico e autoreferenziale sia il mondo dell’editoria che quello dell’accademia. Tutto normale e risaputo.
Allora perchè le storie? Perchè la storia è fatta di storie e dove lo storico (anche quello di strada) deve arrestarsi per rigore metodologico può continuare il narratore. Riprendere quei materiali e andare avanti. La storia che racconto ne “Il patto di Katherine” è ambientata nell’ottobre 1941. Avrei potuto fare una saggio-so come si fa-con note, dati e citazioni. Quanti l’avrebbero letto? Quanto sarebbe servito a dare almeno una informazione in più al malcapitato lettore?
Parafrasando von Clausewitz, il racconto è solo la storia fatta con altri mezzi. Così inizio a raccontare Reggio e il nostro paese in 35 anni di storia, dal 1941 al 1975, attraverso “gli strani casi” di Dario Lamberti, classe 1920, borghese, reggiano, eroe suo malgrado, partigiano, professore di lettere antiche fino alla pensione. Io mi sono divertito, spero che qualcun altro si diverta insieme a me.
Per chiarire (forse) queste confuse noterelle faccio seguire la “Nota dell’autore” del nuovo libro, di cui ringrazio ancora l’Editore Aliberti per la fiducia, al limite dell’incoscienza.
Nota dell’autore
Perché passare dalla storia alle “storie”? In tempi in cui la storia diventa oggetto di riscritture, di spettacolarizzazione, di amnesie più o meno ragionate, anche il confine fra storia e “storie” diventa più sottile. Le opinioni diventano indipendenti dai fatti e tutto tende a confondersi in una drammatizzazione spesso al limite del grottesco.
Ogni ricerca storica tende alla sovrabbondanza, di ipotesi, di percorsi ma soprattutto di materiali della più diversa specie. Materiali che finiscono in un cassetto, su un nastro magnetico, su appunti presi e lasciati inutilizzati. Scrivere “storie” consente di rimettere in circolo questi materiali. Di riciclarli. Una forma di uso ecologico di materiali storici. Storie, vite, episodi, luoghi, ritrovano un loro spazio e, forse, un nuovo senso, fuori dalla gabbia rigida della ricerca storiografica codificata.
Come in un mosaico crollato a terra, si raccolgono le tessere e si ricompone un nuovo disegno. Ogni tessera è originale, un brandello di realtà, ma l’insieme ricostruito non è più storia ma una “storia” possibile fra le tante, uno strumento per raccontare anni lontani e diversi.
Anni lontani e diversi di una città e della sua gente. Una provincia e una terra complicata, con tanta, troppa storia, come qualche amico estero ci ricorda, e dentro uomini e donne, passioni e sentimenti.
Un racconto che inizia con questo primo episodio e che diviene un percorso dal dopoguerra alla vigilia della nostra (post)modernità, attraverso le vicende di Dario Lamberti, professore del Liceo Classico Ludovico Ariosto. Un percorso che non pretende di ridare un senso a 35 anni di storia (le vicende di Dario spaziano tra il 1941 e il 1976) ma, aggirandosi fra quei “sottopassaggi, cripte, buche e nascondigli” che Montale ci racconta, vuole essere un altro punto di vista, il punto di vista di un reggiano che forse è sfuggito a quella “rete a strascico” ma che, come ci conferma il poeta, non solo non è particolarmente felice ma, probabilmente, ignora la sua fortuna.
Migliara, 19 gennaio 2012
 SALUTO DI VITTORIO EMILIANI *
SALUTO DI VITTORIO EMILIANI *