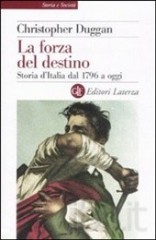Samb Modou 40 anni, Diop Mor 54 e Moustapha Dieng 34 anni. Uccisi perchè neri, perchè invasori, perchè qualcuno pensa di poter usare la parola “razza”, di fare “giustizia”. Non mi interessa se l’assassino fosse pazzo o no: non è molto importante. La storia è nota: si crea la cultura, si inizia un passetto alla volta, una storiella, una battuta. Poi arriva l’esaltato, lo sballato, il fanatico. Si lascia che passino idee, concetti. Quante volte abbiamo sentito la frase “Io non sono razzista, però…” e giù cose orrende su neri, arabi, ebrei, rom e via elencando. E noi ad abbozzare: cosa vuoi, metterti a litigare? In fondo che male c’è, è una battuta…Pochi giorni prima di Firenze, a Torino, è stato bruciato un campo Rom. Qualche protesta, un po’ di strilli e poi? Che dire? Lo sanno tutti che i Rom rubano, no?
L’assassino era di Casa Pound. Strano, pensavo fosse del Rotary o dei cavalieri del S.Sepolcro. Da anni ce li abbiamo davanti, vediamo che prendono spazi che abbiamo abbandonato, un po’ di sdegno, qualche raccolta di firme e amen. Siamo democratici. Vero. Ma la democrazia è una cosa strana, va difesa, va costruita, ogni giorno, non il 25 aprile perchè c’è il sole e siamo di festa. Ogni giorno. Io la chiamo “manovalanza democratica”. La democrazia si difende coi libri, con lo studio, non con le spranghe, qualcuno in passato ci ha creduto e stiamo ancora contando i morti.
Non dovrebbe esserci neppure bisogno di dire che Casa Pound e simili non devono avere spazi, non fisici ma culturali. La democrazia è una cosa delicata: consente la parola anche a chi vuole distruggerla, a noi tocca lavorare perchè quelle parole, quelle battute, quegli slogan cadano su un terreno arido. I fascisti parlino pure ma nessuno dovrebbe stare ad ascoltarli perchè tutti dovrebbero conoscere quella storia, una storia finita per noi italiani il 29 aprile a Piazzale Loreto.
E invece, lo sappiamo, non è così. Il nostro paese non ha mai fatto i conti con il fascismo, è andato avanti e basta. Ha usato la Resistenza come alibi, per lavarsi le mani e la coscienza in un bagno collettivo autoassolutorio, un bel giubileo nel peggior stile cattolico possibile. Un perdono sparso come un bel disinfettante su tutti, innocenti e colpevoli, vittime e carnefici. Passata la febbre ci siamo dichiarati guariti. In realtà, come certe malatte virali, qualcosa ci è rimasto dentro, sembriamo sani, tutto va bene e poi, bang, qualcosa succede. E allora ci guardiamo in faccia, stupiti, increduli. Ma con un po’ di ipocrisia dentro che ben conosciamo.
Il fascismo non è finito a Piazzale Loreto. Abbiamo dato una bella tomba di famiglia al dittatore per consentire agli ammiratori il cordoglio e l’esaltazione. I criminali nazisti sono stati uccisi, cremati e le ceneri sparse al vento. Noi abbiamo perdonato, ma un perdono senza verità è la peggiore ingiustizia.
Si vis pacem para veritatem. Devo questa bella massima all’amico Antonio Brusa ed essa contiene tutto l’impegno culturale, civile ed etico che ci viene richiesto. A noi storici, ai cittadini, agli insegnanti, genitori, persone impegnate in politica.
Anche questi tragici episodi sono l’esito della morte della politica, dell’incapacità di fare scelte e di tenerle ferme, della debolezza di idee e principi che spinge ad accettare anche che organizzazioni fasciste o razziste trovino spazio. Da almeno dieci anni subiamo una metastasi culturale. Abbiamo avuto per anni al governo un partito razzista e xenofobo, ce ne siamo resi conto o abbiamo accettato anche questo come una cosa quasi normale?
Se ci si comincia a convincere che, in fondo, il fascismo è un’opinione come un’altra, magari solo meno elegante, perchè così ci sentiamo più “moderni”, più in sintonia con “i tempi”, siamo già fuori strada, fuori pista, fuori da quella verità che, sola, ci può dare un orientamento, un senso in questi tempi difficili. Il fascismo non è un’opinione è un crimine. L’abbiamo scritto sulle nostre magliette qualche anno fa, per un Viaggio della memoria. Non lasciamo quelle magliette negli armadi.
Ma quanto di questa debolezza diffusa ricade anche sulle nostre spalle? Nel dramma, nel conflitto, ritiriamo fuori il nostro essere “antifascisti”, come una sorta di tachipirina ideologica buona a tutti gli usi. E ci accorgiamo ogni volta che l’Italia antifascista non è e ci sdegnamo perchè gli altri non capiscono. Ma siamo sicuri che quel farmaco sia ancora valido, abbiamo controllato la data di scadenza sulla confezione? Ne abbiamo meditato la storia, valutato il percorso, siamo certi che quella formula non vada rivista, ridiscussa, resa, finalmente, più efficace? O dobbiamo aspettare ogni volta che torni la febbre, che ci vengano i brividi addosso per porci qualche domanda?