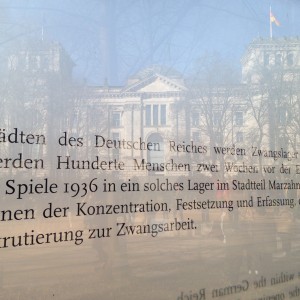Questo è il testo che è stato letto ieri nel corso della visita guidata sui luoghi della repressione fascista a Reggio Emilia, nel quadro del progetto “Oltre il settantesimo”.
Questa è la storia di una strada e di una ragazza. Una ragazza che forse si chiamava Anna o Lucia o Silvana, il nome non ha molta importanza.
La strada è una strada del centro, qui vicina. Ma poi ci arriveremo.
La ragazza nel 1945 aveva 21 anni, compiuti da poco, suo padre un artigiano, sua madre una casalinga, altri fratelli e sorelle. Il posto diciamo fra Cavriago e l’Enza.
21 anni, in quell’inverno finale della guerra, Anna era una staffetta partigiana, in bicicletta, a piedi, un biglietto, una frase, una borsa. Una consegna rapida e via, la paura in gola, sulle strade di campagna. La paura addosso ma anche il pensiero di lui, in montagna, il “moroso” come lo chiamava scherzando sua sorellina, quella piccola. Lui in montagna, a fare il partigiano. Perché era giusto, perché lui aveva coraggio.
Era una mattina di febbraio, in piedi alla fermata della corriera, d’improvviso una voce dietro: “lei è…?” e due mani forti a prenderla. Una macchina nera, quei due in borghese di fianco. Senza una parola. E lei senza chiedere perché.
Giusto il tempo di riconoscere Reggio, i viali, la porta verso Parma. La macchina si ferma, una villetta, un grande cedro davanti.
In piedi davanti a una scrivania, le “generalità”, i “documenti”. Adesso c’è anche gente in divisa, la camicia nera e gli stivali.
“Signorina…” la chiamano, “così giovane”, le dicono. “Non abbia paura, qualche domanda…”.
Cosa rispondere, se sai che hai ancora l’ultimo messaggio infilato in quella piega della giacca? Quasi un colpo di fortuna essere chiusa dentro un gabinetto, in piedi, incantucciata nell’angolo per lo sporco e la puzza. Ma almeno il biglietto sparisce.
Non c’è più luce fuori quando la fortuna finisce.
La vengono a prendere e stavolta non la chiamano più “signorina”, e sorridono e la guardano in un altro modo mentre la portano giù per le scale, in cantina.
Non erano voci straniere, non erano nomi incomprensibili. Quando le hanno strappato i vestiti, quando l’hanno legata. Si chiamavano Manzini, Berti, Barozzi. Nomi delle nostre parti, gente di Reggio. Non erano stranieri quando hanno voluto divertirsi-come diceva il capo- e l’urlo nemmeno le usciva dalla gola, fra l’acqua versata e i colpi che le arrivavano addosso. Forse il tempo si ferma in certi momenti e basta cercare di non pensare. Poi quando tutto finisce il tempo riprende, normale, quasi a dire “si ricomincia a vivere”.
Tre giorni a Villa Cucchi, centro storico, Reggio Emilia, febbraio 1945. Poi la sensazione, inconsapevole che ti prende giorno per giorno, in carcere, che forse sei salva, che forse si sono scordati di te. Altre Anna, altri Giorgio, Marcello. Tu lasciata indietro, lì in un cella ai Servi. Centro storico, Reggio Emilia. Fino a un martedì pomeriggio di aprile, le porte si aprono e capisci che è finita.
Questa è la storia di una strada e di una ragazza. Una ragazza che forse si chiamava Anna o Lucia o Silvana, il nome non ha molta importanza.
La strada è una strada del centro, qui vicina. Adesso ci arriviamo.
Ogni martedì si viene a Reggio, c’è mercato, c’è da andare in giro a fare commissioni. In quell’ufficio Anna deve esserci alle nove, per evitare la coda. Scende dalla corriera alla Sarsa e la strada è facile. Ma non può farla.
Perché questa è anche la storia di una strada sbagliata, una strada dove Anna non può passare. Una volta l’ha fatto, la prima volta. Ora non può più. Perché in quella strada, in centro, qui vicino, c’è un negozio, una banale negozio per gli altri. Ma non per Anna. Una volta c’è passata e sulla soglia c’era lui, uno di quelli che s’erano “divertiti”, una, due, altre volte. L’ha guardata, ha sorriso, i baffetti sui denti guasti. L’ha guardata e le ha fatto quel gesto.
Per sette anni Anna non ha potuto fare quella strada, la strada sbagliata. Ha allungato il cammino, ha affrettato il passo per essere in quell’ufficio alle nove, per evitare la coda. Per sette anni è stata ancora prigioniera.
Poi un martedì mattina, lì vicino, su un muro ha visto quell’avviso funebre. Ha letto il nome, il cognome, “è serenamente spirato” c’era scritto.
Ora poteva passare in quella strada.
Anna mi ha raccontato la sua storia, un pomeriggio, alla fine mi ha detto:
“Sai qual’è stata la cosa peggiore?” E io ho pensato a Villa Cucchi, a quei denti guasti, agli stivali, a una ragazza di 21 anni legata a un tavolo.
“La cosa peggiore, per me, è stata che, quando ho letto quell’annuncio, non ho provato niente. Solo una gran voglia di piangere perché avevo avuto quasi un momento di felicità. Quella è stata la cosa peggiore”.
m.storchi©2009