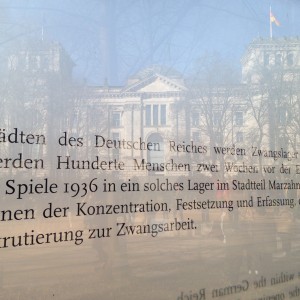La memoria di un testimone della strage della Bettola.
In occasione del 70imo anniversario della strage della Bettola (24 giugno 1944) Istoreco e il Comune di Vezzano hanno promosso una nuova ricerca condotta da Matthias Durchfeld e Massimo Storchi su quella tragica vicenda. Il libro “La Bettola. La strage della notte di S.Giovanni” è stato presentato il 22 giugno a La Vecchia.
Quando il volume era già in corso di stampa è stata reperita questa testimonianza del magg.Tullio De Prato, all’epoca dei fatti collaudatore delle “Reggiane”, contenuta nel suo volume di memorie “Un pilota contadino…dal motore rotativo al jet…”[1]. De Prato possedeva all’epoca un piccolo podere in località Cuccagna, immediatamente sopra la Bettola, dove era sfollato con la famiglia. Da casa sua passarono i partigiani il giorno precedente l’attacco e la notte della strage sulla via della fuga.
La testimonianza è rilevante soprattutto nella parte finale quando racconta l’incontro, all’alba del 24 giugno, sul luogo della strage con i militari tedeschi (erroneamente indicati come facenti parte della SD-Sicherheitdienst) in procinto di rientrare a Casina e l’orrore per la scoperta di quanto accaduto.
Bettola
Con i soldi ricavati dal collaudo del RE2005 m’ero comprato un poderino: pensavo di costruirvi una casa, tra il verde, dove vivere serenamente, con i figli, a guerra finita. Un sogno lontano che mi aiutava a superare tante amarezze. Più che la ferace pianura reggiana mi attraeva la collina. E sui colli che fiancheggiano il Crostolo, avevo individuato il luogo più adatto alle mie ambizioni.
La strada del Cerreto, superata Vezzano e raggiunta La Vecchia, si biforca: la deviazione a sinistra conduce a Montalto. Da Montalto a Cuccagna il percorso è breve e, a ridosso del Monte Duro, in Cuccagna, feci costruire il mio rifugio. Una casetta di proporzioni minime dove non c’erano né acqua né luce elettrica. Vi abbondava, invece, il sole, anche quando la “bassa” era affogata nella nebbia.
La casetta non era ancora ultimata che ci sorprese l’8 settembre: l’armistizio. Reggio Emilia, subito, nella notte sul 9, fu occupata dalla Divisione “Hitler”. Colti alla sprovvista, senza ordini e senza mezzi adeguati, i soldati del presidio si arresero all’alleato, smarriti e fiduciosi. L’alleato, che non era più tale ma “ex”, esprimendo incomprensione, ne caricò in gran numero su lunghi e tranquilli convogli. Anche la città era tranquilla e, nessuno, pensava ai campi di prigionia; nessuno sapeva dei campi di sterminio.
Anche il personale dell’Aeroporto fece la stessa fine e il Colonnello, che aveva mancato alla parola data fu ucciso da un colpo di pistola da un ufficiale germanico[2]. Con i ragazzini ed il “bagaglio” sulla canna della bicicletta anch’io mi avviai fuori città per sfuggire alle inevitabili ricerche. Meta, il mio colle..recondito. Ci alloggiò, alla meglio, il mezzadro del podere confinante e solo dopo una quindicina di giorni potei prendere possesso della mia “proprietà”, ben deciso a non muovermi.
L’illusione ebbe breve durata. Un mattino-presto-mi sentii chiamare per nome. Era il Direttore amministrativo delle “Reggiane” accompagnato da un Capitano tedesco che, maschin-pistole (sic) alla mano continuava a gridare: “Banditen, Partisanen! Kommen sie hier!”. Bellelli, il Direttore, mi fece una quadro della situazione in officina. I tedeschi pretendevano-per meglio controllare la popolazione-che la fabbrica continuasse l’attività e tutti rientrassero ai posti di lavoro. Per i renitenti, la minaccia della deportazione.
Così, in bicicletta com’ero venuto, rientrai a Reggio. Lo stabilimento era presidiato da soldati armati di mitragliatrici, piazzate nei punti più adatti alla sorveglianza. Ciascuno era al proprio posto. Nessuno lavorava ma ognuno borbottava qualcosa al proprio vicino; tirava un’aria da funerale. In città, i tedeschi non si facevano notare, mentre andavano instaurando la loro rigida amministrazione. I fascisti, chiassosi e spavaldi, vivevano di soperchierie. Si diceva, sottovoce, che gli sbandati-per evitare i tedeschi-prendevano la via dei monti e, dopo qualche tempo, si sentì parlare di “partigiani”. Ma non tutti gli sbandati erano animati dalla volontà di combattere gli occupanti; taluni si erano dati alle razzie per sopravvivere. Una sera, un gruppo di questi individui, sprovvisti di armi, era capitato a casa minaccioso per impormi una…tassazione: in caso di rifiuto mi avrebbero sottratto i bambini che stavano dormendo. Pagai la taglia e se ne andarono. Quella visita, però, ne richiamò una seconda. Tre ragazzi, vestiti in modo disuguale e provvisti di una coccarda tricolore al bavero, bussarono alla mia porta per dirmi che..quei delinquenti erano stati individuati e che sarebbero stati puniti. I tre giovani, studenti dall’aspetto e dall’eloquio, rimasero a mangiare un boccone in mia compagnia parlandomi dei loro programmi che, data l’età e l’inesperienza, mi parvero azzardati. Poi, nel buio fitto, scesero verso la sottostante Bettola promettendomi una nuova visita l’indomani. Di due rammento la fisionomie: li rividi, poche ore dopo, uccisi. Uno era biondino, aveva i capelli ondulati e indossava una pseudo-uniforme; l’altro più alto, bruno e robusto, calzava stivali rigidi, neri. La Bettola, una località che sorge nella strettura dove un breve ponte supera il Crostolo, era diventato un posto di “sfollamento”. Il casone, adibito a luogo di sosta per i viandanti, era occupato da cittadini di Reggio che vi si erano sistemati per sottrarsi ai bombardamenti della città. Fra l’altro, i tre ragazzi mi avevano dichiarato che, prima o poi, avrebbero fatto saltare il ponte ed è da supporre che la loro puntata verso il fiume, fosse legata a quel piano. E c’è da supporre anche che quei figliuoli avessero delle conoscenze tra la popolazione della Bettola in buona parte da me conosciuta poiché percorrevo la strada del Cerreto due volte al giorno. Quella sera, ero ancora in piedi quando improvvisamente, udii alcuni spari che provenivano dal fiume. Poi, più nulla.
Stavo andandomene a letto allorché, dalla Bettola, ripresero a sentirsi spari; questa volta più nutriti e raffiche. Le scariche durarono una mezz’ora, poi tornò il silenzio. Un silenzio lugubre, interrotto da crepitii e grida. Il cielo, tenebroso e illune, si andava tingendo di rosso: il casone stava bruciando. Ero uscito nell’aia assieme al mio mezzadro Nearco, quando dal buio sgusciò uno dei tre ragazzi: quello di cui non rammento i lineamenti. Era sconvolto e parlava a fatica anche per l’affanno della corsa. Raccontò confusamente di uno scontro con i tedeschi, della morte dell’amico “biondino”-sul ponte-e del ferimento dell’altro, quello con gli stivali, durante la fuga, su per il ripido tratturo. Colpito da un inseguitore, lo aveva lasciato-morente-ad una cinquantina di metri da casa mia[3]. Mi raccomandò di soccorrerlo e scomparve. Non lo rividi mai più[4].
Subito, assieme al fido e coraggioso Nearco, mi avventurai giù per lo scosceso sentiero e, fatti pochi passi, inciampammo nel corpo senza vita del giovane senza stivali. Mentre, nell’oscurità, cercavamo di orientarci , di fare qualcosa, apparvero due persone anziane le quali abitavano nella vicina “Possessione”. In casa loro si era rifugiato un ferito grave che necessitava di cure.
Sotto di noi, scoppiettando, il casone continuava ad ardere; ne sentivamo il calore. Sarebbe stato indispensabile nascondere il ragazzo morto per evitare che eventuali inseguitori coinvolgessero anche la nostra casa in una azione di rappresaglia. Ma c’era il ferito e corremmo da lui. Aveva la mandibola a penzoloni e ci raccontò, a gesti, più che a parole, la sua avventura. Da lui apprendemmo le proporzioni della tragedia. All’arrivo dei tedeschi, lui si era nascosto nel cesso e quando si era reso conto che tutti gli occupanti il casone erano stati uccisi, era scappato dal finestrino arrampicandosi su per il monte. Scorto da uno dei “giustizieri”, questi gli aveva sparato una raffica raggiungendolo con un proiettile alla bocca.[5] Così conciato, aveva avuto la forza di inerpicarsi fino alla prima casa incontrata.
Poco potemmo per quel poveretto. Lo disinfettammo, lo fasciammo, ma nella zona non esisteva il medico; ed anche rintracciandone uno chi avrebbe osato, in quella notte di spavento, mettersi per strada in compagnia di un ferito della Bettola? Lo sistemammo alla meglio mentre la Bettola continuò a bruciare fino all’alba.
Combattuto fra il desiderio di rendermi utile e la minaccia che gravava sui miei bambini, trascorsi-impotente-il resto della notte sull’aia, con il bravo Nearco. Alle prime luci, da solo, mi buttai giù per i campi, verso il fiume, fiducioso nelle mie risorse di mediocre interprete. Presentandomi sul luogo- ma sarebbe appropriato dire-sulla scena…-dello scontro, un soldato della SD, mi accolse con la maschine-pistole spianata.
Ostentando tranquillità, salutai in tedesco e in tedesco diedi le mie generalità giustificando la mia presenza. Abitavo nei pressi ed ero sceso per…sapere se avevano bisogno di me: il tutto pronunciato nel modo più scorrevole possibile e con l’accento intonato alla lingua di caserma.
Il militare, abbassò la guardia e la…grinta. Mi disse che erano stati attaccati, che avevano ucciso i partisanen e che tutto era finito. Stavano per rientrare. Girai lo sguardo e notai sulla riva del fiume, un gruppetto di soldati che si stava lavando, rassettando. Poco dopo partirono. Rimasi solo in un silenzio agghiacciante. Mi accostai all’area all’area solitamente adibita a sosta dei barrocci che rifornivano di legna la città e mi parve di intravedere, fra i tizzoni ancora accesi, i resti di un vestitino a pois. Esso mi ricordò una bella figliola, ospite del casone: pochi giorni prima, assieme ad altri sfollati, si era spinta fino al mio poderino in una allegra passeggiata. Mi avventurai tra i ruderi del fabbricato e, su un annerito cassone, scorsi un pacco con il mio indirizzo, che continuava a bruciare lentamente. Quasi di corsa, girai intorno a ciò che restava della costruzione senza notare tracce di violenza nei confronti dei suoi abitanti. Ne provai sollievo criticando in cuor mio, quanto narratomi, in preda al panico, dal ferito rifugiato alla “Possessione”. Rinfrancato, corsi al ponte dove, di traverso, giaceva il corpo del “biondino”. Scesi al fiume ed entrai in una casetta misera e priva di vita ma risparmiata dal rogo. In un letto semplice, due poveri vecchi uccisi a colpi di mitra.
Uscii inorridito e, nell’aia, incontrai una bimba-sui quattro anni-denutrita e spaventata[6]. Per caso era sfuggita al massacro. Stava dormendo in mezzo ai nonni, la raffica mortale l’aveva miracolosamente risparmiata ed un soldato germanico…generoso, accortosene, l’aveva poi nascosta dietro un pagliaio per sottrarla all’assassinio.
Insospettito, ritornai tra i resti del casone per osservare meglio quelle braci. Vi notai con raccapriccio resti umani e, sul retro- a terra- un cumulo di cervella! I tedeschi avevano ucciso tutti, grandi e piccini, sparando raffiche alla nuca, bruciando poi i cadaveri sui barrocci accatastati.
Riunendo le poche e imprecise notizie raccolte in seguito, cercai di ricostruire la tragedia che era costata la vita a più di trenta civili innocenti. I tre ragazzi avevano attaccato un automezzo germanico diretto a Casina, sede di distaccamento di polizia. Gli SD a bordo, pur subendo perdite, avevano reagito uccidendo il “biondino” e inseguendo gli altri. Poco dopo, erano ritornati con un autobus di rinforzo e avevano “punito” quelli del luogo…a modo loro.
Passato il comprensibile momento di sgomento profondo, le salme dei due partigiani, con l’aiuto di due militi poco convinti della giustezza della causa, le avviammo-su un carro agricolo-alla estrema dimora. Mi accompagnavano indefinibili rovelli ed interiori preoccupazioni: quale la fine del terzo partigiano? Quale il destino del ferito, sempre ospitato alla “Possessione”?…e la povera bimba sconvolta senza più i nonni trucidati?
Tormenti angosciosi che continuarono a dominare le mie giornate, dopo quella notte davvero indimenticabile. Paventando altre rappreseglie e pensieroso per l’identità razziale dei miei figlioli, decisi di lasciare il mio “rifugio” in collina confondendomi, quasi-mimetizzandomi tra la “folla” cittadina. Una folla minacciosa-rossa o nera che fosse-a me ugualmente sconosciuta.
[1] Tullio de Prato, Un pilota contadino…dal motore rotativo al jet…, Mucchi Editore, Modena 1985. Pag.279-283
[2] Non è stato trovato riscontro di questo episodio. L’unico caduto nelle ore dell’occupazione dell’aeroporto “Bonazzi” di Reggio rimane l’aviere Mario Dirozzi, ucciso il 9 settembre.
[3] Il caduto è probabilmente da identificarsi con Enrico Cavicchioni “Lupo”, comandante del distaccamento che condusse l’azione. Ferito mortalmente nello scontro sul ponte de La Bettola, fu portato verso Monte Duro dai compagni che lo lasciarono, ormai cadavere, proprio nelle vicinanze di casa De Prato (testimonianza di X Lolli, 16 aprile 2014).
[4] Su quanto accaduto nelle notti del 22 e 23 giugno si veda: M.Durchfeld, M.Storchi, “La Bettola. La strage della notte di S.Giovanni”, Istoreco, Comune di Vezzano s/c, 2014,
[5] Si tratta di Romeo Beneventi, gestore della locanda de La Bettola, scampato fortunosamente alla strage con la moglie e la figlia.
[6] Liliana Del Monte, scampata all’eccidio della sua famiglia, all’epoca aveva in realtà undici anni.