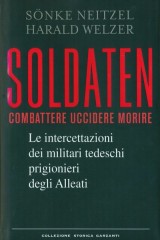di Charlotte Matteini
Nessun diritto al risarcimento per i familiari delle vittime civili della barbarie nazifascista uccisi dalle rappresaglie del Reich alla fine della Seconda guerra mondiale in Italia.
Lo ha decretato la Cassazione, accogliendo un ricorso della Repubblica federale tedesca, recependo l’orientamento espresso a febbraio dalla Corte internazionale di giustizia de l’Aja.
LA PRIMA SENTENZA CONDANNÒ LA GERMANIA. La prima sezione penale della Suprema Corte ha annullato, senza rinvio, il verdetto emesso il 20 aprile 2011 dalla Corte militare di Appello di Roma che dichiarava la Germania responsabile civile dell’eccidio di 350 civili uccisi nell’agosto del 1944 tra Fivizzano e Fosdinovo, in provincia di Massa.
La sentenza riconosceva agli oltre 60 familiari delle vittime un risarcimento complessivo di circa cinque milioni di euro e alla Regione Toscana, costituitasi parte civile assieme ai due Comuni, era invece stata accordata una provvisionale di 40 mila euro.
Stessa cifra liquidata, come acconto su un totale da determinare, anche alle amministrazioni comunali di Fivizzano e Fosdinovo.
Negli anni passati, invece, la Cassazione aveva confermato il diritto dei familiari delle vittime a essere risarcite e lo stesso discorso valeva anche per i cosiddetti ‘schiavi di Hitler’, gli italiani – militari e civili – deportati in Germania a lavorare nell’industria bellica.
«Le stragi di civili sono un crimine mostruoso per il quale la Germania riconosce la sua responsabilità morale e chiede perdono al popolo italiano e ai familiari delle vittime, questa é la prima cosa che voglio dire con chiarezza», ha affermato l’avvocato Augusto Dossena, che ha presentato il ricorso della Repubblica federale tedesca in Cassazione.
«Con questa decisione» ha spiegato Dossena «credo che la Cassazione abbia recepito la sentenza de L’Aja che ha dichiarato che anche per i crimini di guerra vale il principio della immunità civile degli Stati».
«Questo non vuol dire che la Germania non pagherà indennizzi perché la Corte non ha detto questo: ha detto, invece, che questa materia» ha proseguito il legale «deve essere definita con gli strumenti diplomatici, dunque con un dialogo tra Stati, e non per vie giudiziali. Contatti in tal senso già ci sono stati tra Roma e Berlino».
«LA CASSAZIONE HA TENUTO CONTO DELL’AJA». In attesa di conoscere le motivazioni dei supremi giudici – entro 90 giorni – Dossena ha aggiunto che «per ora, posso solo dire che la procura della Cassazione, senza entrare nel merito del ‘giusto’ o ‘sbagliato’, ha sostenuto, che era necessario tenere conto di quanto stabilito dalla Corte Internazionale».
Sul fronte delle responsabilità penali dei militari nazisti, Dossena ha sottolineato che «sono passate in giudicato, e dunque, sono definitive, le condanne all’ergastolo dei quattro imputati: Joseph Bauman, Wilhelm Kusterer, Max Schneider e Helmut Wulf».
L’avvocato ha però notato che i quattro «non hanno nemmeno fatto ricorso contro la sentenza di appello, forse sono deceduti, come è accaduto per altri quattro coimputati».
Sono circa 60 le cause risarcitorie pendenti, in diverso grado, nelle aule di giustizia italiane per crimini di guerra commessi dai militari nazisti.
A Como, il tribunale civile deve riprendere il procedimento con il quale la Germania chiede la liberazione di Villa Vigoni, il prestigioso centro di studi tedesco sul lago di Como, dall’iscrizione ipotecaria chiesta dai parenti delle vittime della strage di Civitella.
GERMANIA CONTRO ROMA. Invece a Roma, il tribunale, a settembre, deve decidere sulla richiesta di opposizione avanzata sempre dalla Germania contro il tentativo di «esecuzione presso terzi» con il quale i greci dell’eccidio di Distomo chiedono il sequestro di circa 40 milioni di euro che le Ferrovie tedesche avrebbero, secondo i legali dei greci, sotto forma di credito presso le Ferrovie dello Stato italiane.
Finora il tentativo di esecuzione non è andato a buon fine perché non è risultato alcun credito.
A ogni modo, in giudizio si sono costituite, oltre alla Germania, anche le ferrovie tedesche e quelle italiane.
Mercoledì, 30 Maggio 2012
http://www.lettera43.it/politica/stragi-nazifasciste-nessun-risarcimento_4367552763.htm