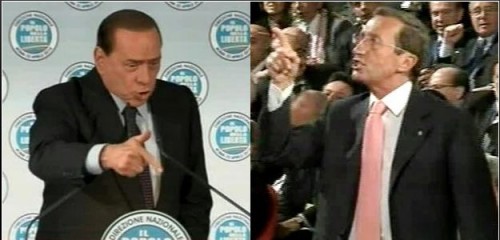Cervarolo. La storia e la memoria
La strage del 20 marzo 1944 insieme a quella della Bettola del 24 giugno rappresentano i due episodi più drammatici in provincia di Reggio Emilia di quella che fu la guerra “auch gegen Frauen und Kindern (anche contro donne e bambini)” condotta dalle truppe tedesche e fasciste nei venti mesi di occupazione del paese. Due stragi, diverse per dinamiche, autori, tipologia delle vittime e costruzione della memoria , che hanno però lasciato un segno forte nell’identità collettiva.
Ma se la strage di Bettola non poteva far riferimento ad una comunità univocamente individuata (le vittime erano ospiti occasionali della locanda sulla SS63), Cervarolo, invece, è riuscito ad assumere e rielaborare il proprio tragico vissuto non solo con la ricostruzione fisica del paese nel dopoguerra ma anche con la conservazione di una memoria collettiva e di rapporti intracomunitari forti, suggellati ogni anno dall’incontro conviviale che si tiene proprio nello stesso luogo dell’eccidio, quasi a “riconsacrare” quel luogo di morte e riconsegnarlo alla sua funzione storica di luogo di lavoro, d’incontro e di festa, tragicamente infranta in quel lunedì di marzo.
Una memoria forte e una salda consapevolezza, sorretta nei decenni anche dalle amministrazioni pubbliche e dalle associazioni partigiane, ma che non aveva mai potuto trovare il riscontro della giustizia a sanzionare le responsabilità di quel crimine. Prima la concessione dell’amnistia verso i fascisti repubblicani aveva cancellato, già nel 1946, le colpe di quanti, seppur con compiti di supporto e spionaggio, avevano contribuito alla tragedia, poi la scelta, compiuta nel 1960 di relegare in un armadio presso la Procura militare di Roma i 695 fascicoli relativi alle 2273 stragi compiute in Italia da tedeschi e fascisti ha impedito fino al maggio 1994, quando i fascicoli furono ritrovati ed inviati alle Procure Militari competenti per territorio, di garantire a quella stessa comunità di Cervarolo, fra le tante altre, un percorso di giustizia e di affermazione di una verità giudiziaria .
L’impegno, la capacità e la caparbietà (si consenta il termine) degli inquirenti in questi anni hanno portato all’avvio di questo percorso di giustizia e verità.
Sulla strage, in questi 65 anni, sono stati editi tre testi ma solo con gli studi di Carlo Gentile e il saggio di Giovanni Fantozzi del 2006 è stato possibile inquadrare in maniera compiuta e precisa, ricorrendo finalmente ad inequivoche fonti documentarie tedesche, gli avvenimenti del 20 marzo a Cervarolo nell’ambito delle azioni di strage e rappresaglia condotte dall’esercito tedesco sul nostro Appennino nella primavera del 1944.
Diversamente da quanto verificato dalla storiografia sull’argomento in relazione ad altre stragi compiute da truppe tedesche e fasciste nel 1944, non è si è consolidata, nel caso di Cervarolo, una memoria “divisa”, cioè, una memoria sostanzialmente antipartigiana che identifica nelle azioni armate delle bande partigiane operanti nella zona la causa scatenante della distruzione portata dalle truppe tedesche con il sostegno logistico e operativo dei reparti repubblicani. Al contrario proprio la riapertura delle indagini e l’avvio del processo hanno confermato la partecipazione compatta dei congiunti e discendenti delle vittime alla richiesta di una punizione dei responsabili, i militari tedeschi della Divisione Hermann Göring.
Solo negli ultimi anni, nel clima di un generalizzato e sconclusionato “processo alla Resistenza” anche la strage di Cervarolo è stata utilizzata strumentalmente in chiave antipartigiana, suggerendo pretestuosamente un legame causa-effetto tra gli avvenimenti seguenti allo scontro di Cerrè Sologno (fucilazione di alcuni prigionieri a Monte Orsaro) e l’azione di rappresaglia del 20 marzo. Un legame che non è possibile rintracciare non solo in nessun documento ufficiale tedesco sull’accaduto, dove l’obiettivo Cervarolo viene identificato in quanto luogo di appoggio e residenza di “ribelli” e l’azione viene decisa nonostante la consapevolezza dell’avvenuto spostamento delle bande partigiane dalla zona (e non viene quasi fatta menzione dell’uccisione di propri militari), ma neppure nella stessa lettera del vescovo Brettoni inviata, quasi un mese dopo, a Papa Pio XII, informandolo dell’accaduto:
Ho chiesto al capo della Provincia e al Comandante della Milizia quale reato sia stato riconosciuto o attribuito al parroco don Pigozzi per scusare un trattamento così inumano, con anche il ludibrio della denudazione. Nulla sono riuscito a conoscere di concreto se non che, essendo Cervarolo tenuto come molto favorevole ai partigiani, i tedeschi hanno compiuto contro di esso una spedizione di rappresaglia, non solo per punire il passato ma per incutere terrore per l’avvenire. Ma il parroco si era tenuto sempre alieno, assolutamente, da qualsiasi favoreggiamento ai partigiani, dai quali, anzi, temeva qualche rappresaglia. La morte del buon parroco don Pigozzi ha destato in tutta la Diocesi, specie nel clero, molto rimpianto .
La lettura dell’accaduto è tutto in quella rappresaglia compiuta “non solo per punire il passato ma per incutere terrore per l’avvenire.”
E’ la stessa vicenda della borgata prima e dopo l’8 settembre a decretarne la condanna alla distruzione. In quel lunedì viene in qualche modo a soluzione il contrasto di lungo periodo fra il villaggio sovversivo di Cervarolo, fatto di operai, contadini migranti e antifascisti e i limitrofi centri fascisti, il capoluogo Villaminozzo ma, soprattutto, Gazzano. Cervarolo viene colpita con una strage insieme punitiva e preventiva, preparata con una sorveglianza attenta prima e poi non solo con l’azione di due spie locali che informeranno e guideranno i militari, ma anche con l’invio di spie giunte dall’esterno nelle settimane precedenti .
Da questi elementi matura la tragedia di Cervarolo che si compie in una fase in cui si fronteggiavano, sulle opposte sponde, le diverse debolezze delle parti in campo. Da un lato una resistenza ancora embrionale, che chiude la sua prima fase dopo il vittorioso scontro di Cerrè Sologno con il ferimento dei suoi comandanti e con lo sbandamento della banda reggiano-modenese che aveva condotto le azioni delle prime settimane di lotta. Dall’altro la tragica alleanza fra un rinato fascismo, già macchiatosi delle stragi dei Cervi e di don Pasquino Borghi, ma incapace a svolgere i compiti di controllo del territorio (e costretto per questo, nei confronti dell’alleato, a ingigantire, scientemente, il pericolo effettivo dei “ribelli”) e la presenza tedesca ancora vincolata alla prima fase di repressione delle bande, quella che poteva immaginare una loro completa distruzione attraverso attacchi mirati di altissimo impatto svolti da truppe specializzate (come era la Divisione Hermann Göring) nelle politiche di massacro di civili.